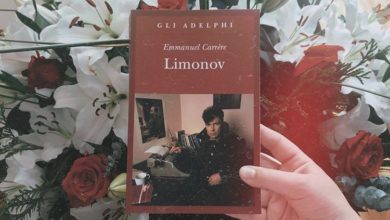Oggi 25 novembre, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (se non sapete il motivo per cui questa giornata è stata istituita proprio oggi, vi lascio uno spunto qui) vi voglio proporre una riflessione, che è nata in me a partire da un incontro di Inquiete Festival con Book Pride, lo scorso ottobre. Ma anche riflettendo sulla mia stessa situazione di giovane laureata in cerca di un posto (di lavoro) nel mondo.
Se pensiamo allo stereotipo che ci tramanda la storia, l’editore/imprenditore è uomo, il correttore di bozze è femmina. Ma partiamo con i dati pubblicati da InGenere nel 2018.
Le donne occupano principalmente i ruoli “di cura” della filiera: editor, traduttrici, redattrici, lettrici professioniste. La loro presenza diminuisce man mano che ci si avvicina agli apici dirigenziali: nel 2018 il 22,3% di questi sono donne (tra CEO, presidenti, amministratori delegati e direttori generali) contro il 77,7% di uomini nelle stesse posizioni. Nel 2010 la percentuale femminile si arrestava al 16,6%.
Scrive Sofia Biondani per InGenere: “La massiccia presenza femminile tra le fila di chi concretamente lavora al prodotto libro, pur non detenendo potere decisionale, prospetta una emergenza precariato, specialmente tra le giovani lavoratrici, in un settore sempre in bilico tra imprese miliardarie e artigianato culturale. Si tratta, tuttavia, anche di un punto di forza che è possibile mettere a valore, dando sostanza a una ossatura del mercato massimamente femminile.”
Ma forse dobbiamo fare un passo indietro, ovvero partendo da chi i libri li scrive. Tra gli scrittori che nel 2017 hanno pubblicato narrativa per adulti, il 38,3% sono autrici. Questo dato è in crescita e oggi, nel 2020, possiamo dire che per quanto riguarda la narrativa ci troviamo ad un 50 e 50 di presenza maschile e femminile. Nella saggistica purtroppo il divario è più ampio. Dove il pensiero e l’approfondimento conta, le donne sono ancora una minoranza e c’è ancora tanta strada da fare. Esiste un problema di canone, dove non c’è autorevolezza per le donne: bisognerebbe spingere il canone, cercare di ampliarlo, attraverso la scelta di libri che si situano nel discorso pubblico e che lo spostano di un po’.
Passando al piano dei premi letterari, ossia un piano di riconoscimento autoriale, i numeri raccontano una storia ben diversa. Soprattutto se si pensa che le vittorie dei premi letterari sono influenti non solo sotto il profilo culturale, ma anche sotto quello del mercato, condizionando soprattutto lettori e lettrici occasionali. Nelle 74 edizioni del Premio Strega, sono state solo 11 le autrici vincitrici, 14 su 57 al Campiello, 12 dal 1953 a oggi al Premio Bancarella.
Anche scorrendo i cataloghi delle case editrici si nota come i nomi femminili si concentrino specialmente in quelli di case editrici come Harper Collins o Sperling & Kupfer, celebri per il pubblico femminile e la pubblicazione di romanzi “rosa” o “da ombrellone”.
È vero che i dati stanno cambiando, ma la strada da fare è lunga. È incoraggiante pensare che il vincitore del Premio Strega di quest’anno viene da una casa editrice di una donna (La Nave di Teseo, di Elisabetta Sgarbi); la rappresentante della narrativa italiana all’estero è Elena Ferrante; chi ha dominato le classifiche di questo ultimo anno e mezzo, è una grande scrittrice, Stefania Auci. La difficoltà, secondo me, rimane nell’ambito scolastico. Quante donne, scrittrici si studiano? Poche, pochissime. A volte nessuna. Se devo pensare al mio percorso scolastico, credo di non aver incontrato mai nei miei libri di testi autrici donne, se non, forse, alcune poetesse. Cosa vuol dire questo? Che la parità di genere non viene insegnata a scuola, che a lungo andare questo diventerà il canone (ma già lo è) e tante, troppe autrici finiranno nel dimenticatoio e chi verrà portato avanti dalla memoria saranno solo autori maschi, di indubbio valore, ma quantitativamente troppi.
Il problema sorge anche quando si parla di dirigenze e ruoli apicali: lì la situazione è statica e complessa. C’è necessità di indagare più a fondo quali carriere intraprendano le donne e con quali prospettive. Riprendo una riflessione di Michela Murgia, fatta proprio in concomitanza con la giornata odierna. La maggior parte delle donne vittime di violenza, sono donne che non hanno un’indipendenza economica e per questo si ritrovano a dover sottostare a una situazione dannosa e nociva. La violenza comincia prima dello schiaffo, comincia negando la parità. Lottare per la parità di salario a parità di genere è uno degli strumenti di prevenzione della violenza, non perché fermi la violenza ma perché permette alle donne di scegliere di andarsene senza temere di non poter mantenere sé stesse e i figli.
Consiglio a tutti quelli che leggeranno questo articolo di ascoltare il podcast Musecolmuso, di Beatrice Carvisiglia e Lucia De Angelis, in particolare la puntata Uomini che non leggono le donne, in cui si discute di sessismo nella cultura e nell’editoria. Fondamentale per tutti.
E mi raccomando, parliamone sempre, tutti i giorni, con tutti, e non solo oggi.